In rete, nello spazio www.sfi.it, potete scaricare gratuitamente una rivista di didattica della filosofia dal titolo “Comunicazione filosofica”. Nell’ultimo numero (39) è ospitata anche una mia RECENSIONE a
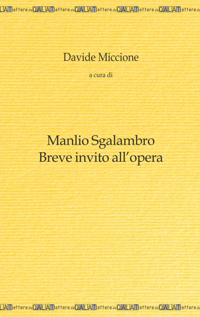
Quel poco che conoscevo di Manlio Sgalambro non mi aveva stuzzicato il desiderio di saperne di più. Ma l’incontro con questo bel libro a quattro firme (Manlio Sgalambro. Breve invito all’opera, a cura di Davide Miccione, Lettere da Qalat, Caltagirone 2017, pp. 197, euro 15,00) mi ha indotto a cambiare idea e a constatare che, davvero, ora che è morto, “tra i tanti esemplari umani ormai riducibili a pochi tipi, e noiosamente ritornanti sul proscenio del presente, Sgalambro spicca sempre di più” (p. 8).
Il primo capitolo, di Davide Miccione, è dedicato a I molti nomi del filosofo o, come spiega meglio il sottotitolo, a delineare La figura del pensatore in Manlio Sgalambro. Più che in positivo, tale figura viene ricavata in negativo, sulla base delle idiosincrasie del pensatore siciliano: non è un accademico né un docente di scuola dal momento che – secondo la sintesi efficace di Miccione – per Sgalambro “lo spirito soffia dove vuole, ma non in un’aula” (p. 30); non è un erudito (“In filosofia non è ammessa ‘cultura’. Il corpo a corpo con lo spirito è un’altra cosa. Cultura è ciò che resta dopo che lo spirito se ne è andato”, p. 31); vive appartato e solitario; pericoloso per l’uomo comune almeno quanto l’uomo comune lo è per il filosofo; dedito a un sapere che – del tutto controcorrente – è “luogo delle certezze e non dei dubbi, della chiusura nel sistema come forma ideale, del rifiuto di una storia della filosofia, del rifiuto dell’ermeneutica, insomma del rifiuto di tutte quelle dimensioni che possono permetterci di articolare la convivenza tra filosofie diverse senza postulare che ve ne possa essere solo una” (p. 36). Il filosofo è “chierico” (p. 38), “teologo” (p. 40) sia pure di una religione empia, “conoscitore” e “avventuriero” (p. 44), “scrittore di filosofia” o, per essere più precisi, dell’“opera filosofica” (p. 48).
Ma quali sono i contenuti precipui di quest’opera filosofica sgalambriana? Nel suo saggio Manlio Sgalambro: pessimismo e misoteismo Salvatore Ivan D’Agostino individua due principali linee teoretiche: “il pessimismo di derivazione schopenhaueriana” (p. 51) e l’“odio per Dio” (p. 61) che è spesso “una reazione emozionale alla sindrome di Stoccolma religiosa secondo la quale siamo costretti più o meno consapevolmente ad amare l’essere (supposto) che ci tiene in miseria, ci fa soffrire ed alla fine immancabilmente ci uccide” (p. 76). Da queste due matrici si generano diversi frutti, più o meno avvelenati, tra cui l’“antinatalismo” (per usare l’etichetta di David Benatar) o, più semplicemente, la tesi che non nascere è da ogni punto di vista preferibile a nascere.
Sgalambro ha affidato la sua filosofia anche alle composizioni in versi: di queste si occupa, con fine erudizione, Giovanni Miraglia nel suo Caravanserraglio d’argomenti. Manlio Sgalambro o della impoesia. Al suo sguardo il pensatore di Lentini appare come un antico greco per il quale “non v’erano precisi confini tra pensiero astratto, scienza, musica e letteratura” (p. 85). Ma se allora la poesia poteva aspirare a una funzione religiosa o civica, Sgalambro si dedica invece a sopprimere ogni “funzione salvifica”, “in primis per mezzo dell’ironia” (p. 91). Un’ironia che giunge dalle “lande teutoniche, forgiata nella fucina romantica e idealistica” e avente “il suo perno nel comico come frutto della contraddizione” o, per dirla con Kant, “il dissolversi nel nulla di un’attesa vivissima” (p. 94). Miraglia ripercorre con dovizia di collegamenti le “quattro stazioni” in cui è “scandito il cammino impoetico di Manlio Sgalambro” (p.83): ma, in questa sede, non possiamo che rimandare alle sue pagine così dotte.
Il quarto e ultimo saggio del volume (Un cavaliere dell’intelletto: Manlio Sgalambro), di Cosimo Cucinotta, esamina il testo del libretto di un’opera lirica – Il cavaliere dell’intelletto, appunto – dedicata a Federico II, nell’ottavo centenario della nascita, che il filosofo siciliano scrisse per Franco Battiato. La figura del sovrano svevo-normanno che emerge è complessa almeno come pare sia stata storicamente: “si dichiara consapevole della natura della Verità, una natura effimera e leggera come quella di una cortigiana, che i ragionamenti del filosofo possono solo corteggiare, laddove l’autorità imperiale la possiede totalmente, poiché essa è cosa da re non da filosofo” (pp. 109-110). Sul finire dell’opera, Federico II proclama il “suo messaggio estremo: tra il nascere e il morire – i soli momenti reali – si svolge un sogno ininterrotto da qualche brivido di veglia. Ogni sua azione non è stata altro che un gesto vuoto e senza significato, un guscio arido. L’eroe che ha sempre creduto di agire comprende, rimasto solo sulla scena, che anche l’azione evapora nel nulla e che non gli è stato dato altro destino che non fosse la consapevolezza estrema di essersi vanamente agitato. Il suo impero è stato anch’esso un sogno, destinato a cadere in rovina, un progetto nel cui divenire si occultava la morte e di cui sopravvivono solo le parole friabili di cui era fatto: solo le parole restano” (pp. 123-124).
Augusto Cavadi



