• Augusto Cavadi •

La forsennata super-produzione industriale (dettata da interessi privati e/o di Stati nazionali) è alla radice dei conflitti bellici in corso (con relativi rischi di esiti nucleari) e della distruzione irreversibile dell’ambiente.
I politici sono, di norma, un ostacolo anziché un sostegno per la risoluzione di questi drammi epocali nel loro intreccio micidiale. Come confermano le ultime elezioni italiane del 25 settembre 2022, i cittadini o si astengono dal far pesare il loro voto o lo indirizzano preferibilmente su schieramenti sfacciatamente filo-capitalistici che non hanno, neppure solo a livello programmatico, l’intenzione di ridurre sfruttamento delle risorse, situazioni di guerra, disastri ecologici.
Inorridito da questo “sonnambulismo” generalizzato, a 101 suonati, uno dei massimi pensatori viventi – Edgar Morin – ha lanciato il suo grido d’allarme: "Svegliamoci!" (Mimesis, Milano–Udine 2022, pp. 78, euro 10,00).
Svegliamoci da questo sonno dogmatico provocato o dall’illusione che l’umanità non compia l’ultimo miglio verso l’auto-distruzione definitiva o dalla convinzione nichilistica che questo suicidio collettivo non sia il peggiore dei mali dal momento che l’essere, la vita, la gioia, la solidarietà, il piacere sarebbero – tutto sommato – equivalenti al nulla, alla morte, al dolore, all’individualismo, all’insensibilità.
I politici sono, di norma, un ostacolo anziché un sostegno per la risoluzione di questi drammi epocali nel loro intreccio micidiale. Come confermano le ultime elezioni italiane del 25 settembre 2022, i cittadini o si astengono dal far pesare il loro voto o lo indirizzano preferibilmente su schieramenti sfacciatamente filo-capitalistici che non hanno, neppure solo a livello programmatico, l’intenzione di ridurre sfruttamento delle risorse, situazioni di guerra, disastri ecologici.
Inorridito da questo “sonnambulismo” generalizzato, a 101 suonati, uno dei massimi pensatori viventi – Edgar Morin – ha lanciato il suo grido d’allarme: "Svegliamoci!" (Mimesis, Milano–Udine 2022, pp. 78, euro 10,00).
Svegliamoci da questo sonno dogmatico provocato o dall’illusione che l’umanità non compia l’ultimo miglio verso l’auto-distruzione definitiva o dalla convinzione nichilistica che questo suicidio collettivo non sia il peggiore dei mali dal momento che l’essere, la vita, la gioia, la solidarietà, il piacere sarebbero – tutto sommato – equivalenti al nulla, alla morte, al dolore, all’individualismo, all’insensibilità.
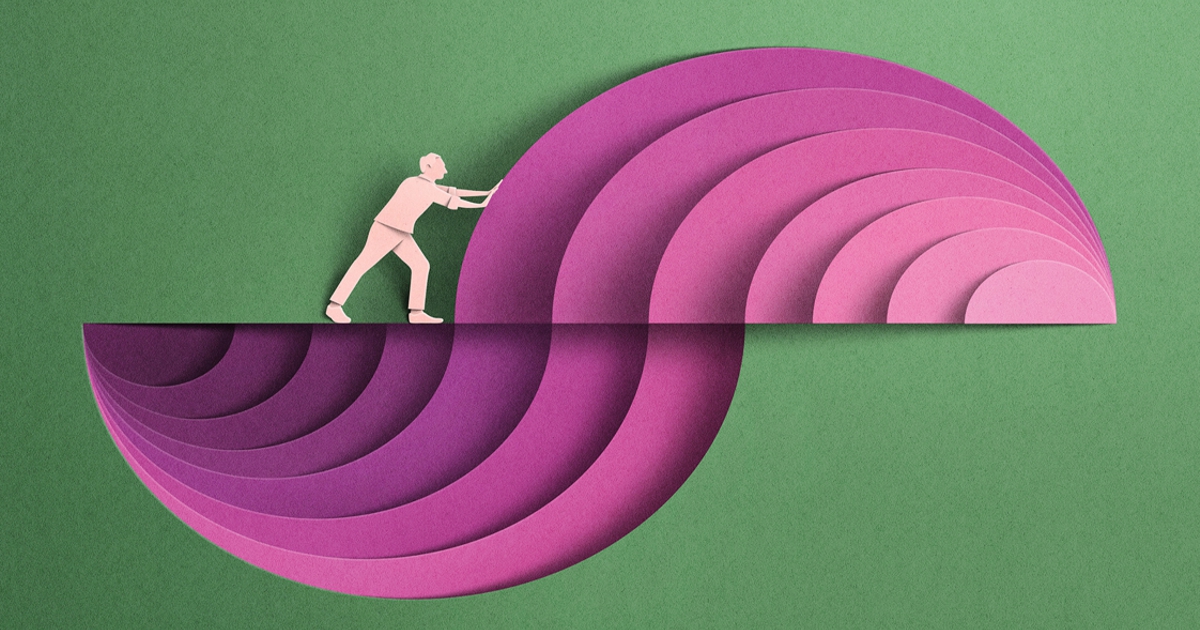
Cosa significa, in concreto, svegliarsi?
Quasi a mo’ di sintesi dei suoi innumerevoli scritti, Morin lo spiega efficacemente in questo opuscolo. Non tento neppure di riassumere le sue indicazioni articolate, mi limito al passaggio che mi sembra la chiave di lettura decisiva: “Non è solo la crisi dei partiti di sinistra in rovina, né soltanto la crisi della democrazia che imperversa in tutto il mondo, né solo la crisi di uno Stato iperburocratizzato e appesantito dalle lobby, né ancora soltanto la crisi di una società dominata dal potere onnipresente del profitto, né infine solo una crisi della civiltà o dell’umanesimo, si tratta di una crisi più radicale e nascosta: una crisi del pensiero” (p. 31).
Già sarebbe abbastanza grave vivere in contesto politico in cui ministri della Repubblica insegnano ai giovani che “con la cultura non si mangia” (Giulio Tremonti) e in cui quei giovani, che – invece – vorrebbero mangiare grazie al lavoro culturale, sono costretti a emigrare nei cinque continenti; ma c’è di peggio. Artisti e ingegneri, chimici e letterati, economisti e archeologici, fisici e psicologi – anche i più esperti fra queste categorie di intellettuali – si accontentano del loro punto di vista particolare e non aspirano neppure a una prospettiva complessiva: “gli specialisti disdegnano ogni conoscenza globale, che considerano superficiale.[...] L’invisibilità della crisi del pensiero dipende dalla separazione e dalla frammentazione delle conoscenze, la cui riunificazione è considerata impossibile, rendendo quindi unilaterale, incompleta e di parte ogni considerazione relativa alla società, alla storia e alle crisi medesime” (p. 47).
 Chi dovrebbe prestare il servizio della sintesi, della trans-disciplinarietà, dello sguardo unitario, sapienziale, comprensivo?
Chi dovrebbe prestare il servizio della sintesi, della trans-disciplinarietà, dello sguardo unitario, sapienziale, comprensivo?
In Occidente è stata questa la missione dei filosofi. Ma, da almeno un secolo, la filosofia (nelle università e di conseguenza nelle scuole medie) è diventata storia della filosofia. Indubbiamente nessun filosofo saggio comincia a filosofare in prima persona senza studiare attentamente le filosofie precedenti: ma, se ci si limita a questa indagine archeologica del passato, chi oserà proporre un’analisi complessiva del presente e, addirittura, un progetto per il futuro?
Nel Novecento F. Waismann (in Analisi linguistica e filosofia, Astrolabio Ubaldini, Roma 1970, p. 40) ha scritto che la filosofia autentica è “lo sfondamento della morta incrostazione della tradizione e delle convenzioni, la rottura delle catene che ci legano ai preconcetti che abbiamo ereditato dal passato, in modo che si possa ottenere una nuova e più potente visione delle cose”. Senza la filosofia così intesa, chi darà alla classe dirigente di un Paese (classe che include i politici, ma non solo) gli elementi affinché, restando ciascuno e ciascuna nel proprio ambito professionale, si elabori – ‘per’ e soprattutto ‘con’ l’intera popolazione – una saggezza condivisa? Se anche i filosofi si concentrano sul dettaglio del dettaglio (dedicando la vita a leggere e commentare un solo pensatore per quanto illustre, anzi una sola opera di un solo pensatore), perché meravigliarsi di tanta miopia fra eletti ed elettori, governanti e governati? Con felice espressione, Gerd Achenbach ha definito il filosofo “lo specialista del generico”: ma quanto coraggio ci vuole a intraprendere questa strada sapendo che le accademie aprono le porte solo a quanti dimostrano di sapere quasi tutto su un quasi niente? E’ un po’ come quella figura, in via di eclissi, del buon medico di famiglia: di ortopedia o di dermatologia ne sa meno dei colleghi ortopedici o dermatologi, ma – se davvero esperto – sa qualcosa che tutti i suoi colleghi specialisti, sommati insieme, ignorano. Possiede quello sguardo clinico che coglie il paziente nella sua interezza: uno sguardo olistico in grado di afferrare le connessioni fra gli organi dell’unico soggetto (somato-psichico) davvero esistente. Forse è tornato il tempo in cui – come avveniva dal V secolo a. C. al XIX secolo d.C. – il filosofo non era un professore di filosofia, ma uno scienziato o un avvocato, un diplomatico o un pulitore di lenti, un medico o un prete: uno che aveva il suo mestiere per mantenersi, cercava di svolgerlo con il massimo di attenzione e di cura, ma senza spegnere la passione per interpretare la Totalità. Uno fra tanti, uno come tanti, abitato però dal desiderio di vivere “come colui che ha visto molto e non ha dimenticato nulla, e come uno che vede ogni cosa per la prima volta” (J. Wisdom, Paradox and Discovery, Blackwell Publishers, Oxford 1966, pp. 137-138).
Di storici delle filosofie ne abbiamo molti, e tra questi anche di molto bravi nell’esegesi dei testi in ogni lingua antica o moderna. Ma di cercatori di sapienza, che si sforzino – in e oltre la propria attività lavorativa – di pensare con originalità senza asservirsi né alla carriera né alle mode né ai potenti di turno, abbiamo disperato bisogno.
Quasi a mo’ di sintesi dei suoi innumerevoli scritti, Morin lo spiega efficacemente in questo opuscolo. Non tento neppure di riassumere le sue indicazioni articolate, mi limito al passaggio che mi sembra la chiave di lettura decisiva: “Non è solo la crisi dei partiti di sinistra in rovina, né soltanto la crisi della democrazia che imperversa in tutto il mondo, né solo la crisi di uno Stato iperburocratizzato e appesantito dalle lobby, né ancora soltanto la crisi di una società dominata dal potere onnipresente del profitto, né infine solo una crisi della civiltà o dell’umanesimo, si tratta di una crisi più radicale e nascosta: una crisi del pensiero” (p. 31).
Già sarebbe abbastanza grave vivere in contesto politico in cui ministri della Repubblica insegnano ai giovani che “con la cultura non si mangia” (Giulio Tremonti) e in cui quei giovani, che – invece – vorrebbero mangiare grazie al lavoro culturale, sono costretti a emigrare nei cinque continenti; ma c’è di peggio. Artisti e ingegneri, chimici e letterati, economisti e archeologici, fisici e psicologi – anche i più esperti fra queste categorie di intellettuali – si accontentano del loro punto di vista particolare e non aspirano neppure a una prospettiva complessiva: “gli specialisti disdegnano ogni conoscenza globale, che considerano superficiale.[...] L’invisibilità della crisi del pensiero dipende dalla separazione e dalla frammentazione delle conoscenze, la cui riunificazione è considerata impossibile, rendendo quindi unilaterale, incompleta e di parte ogni considerazione relativa alla società, alla storia e alle crisi medesime” (p. 47).

In Occidente è stata questa la missione dei filosofi. Ma, da almeno un secolo, la filosofia (nelle università e di conseguenza nelle scuole medie) è diventata storia della filosofia. Indubbiamente nessun filosofo saggio comincia a filosofare in prima persona senza studiare attentamente le filosofie precedenti: ma, se ci si limita a questa indagine archeologica del passato, chi oserà proporre un’analisi complessiva del presente e, addirittura, un progetto per il futuro?
Nel Novecento F. Waismann (in Analisi linguistica e filosofia, Astrolabio Ubaldini, Roma 1970, p. 40) ha scritto che la filosofia autentica è “lo sfondamento della morta incrostazione della tradizione e delle convenzioni, la rottura delle catene che ci legano ai preconcetti che abbiamo ereditato dal passato, in modo che si possa ottenere una nuova e più potente visione delle cose”. Senza la filosofia così intesa, chi darà alla classe dirigente di un Paese (classe che include i politici, ma non solo) gli elementi affinché, restando ciascuno e ciascuna nel proprio ambito professionale, si elabori – ‘per’ e soprattutto ‘con’ l’intera popolazione – una saggezza condivisa? Se anche i filosofi si concentrano sul dettaglio del dettaglio (dedicando la vita a leggere e commentare un solo pensatore per quanto illustre, anzi una sola opera di un solo pensatore), perché meravigliarsi di tanta miopia fra eletti ed elettori, governanti e governati? Con felice espressione, Gerd Achenbach ha definito il filosofo “lo specialista del generico”: ma quanto coraggio ci vuole a intraprendere questa strada sapendo che le accademie aprono le porte solo a quanti dimostrano di sapere quasi tutto su un quasi niente? E’ un po’ come quella figura, in via di eclissi, del buon medico di famiglia: di ortopedia o di dermatologia ne sa meno dei colleghi ortopedici o dermatologi, ma – se davvero esperto – sa qualcosa che tutti i suoi colleghi specialisti, sommati insieme, ignorano. Possiede quello sguardo clinico che coglie il paziente nella sua interezza: uno sguardo olistico in grado di afferrare le connessioni fra gli organi dell’unico soggetto (somato-psichico) davvero esistente. Forse è tornato il tempo in cui – come avveniva dal V secolo a. C. al XIX secolo d.C. – il filosofo non era un professore di filosofia, ma uno scienziato o un avvocato, un diplomatico o un pulitore di lenti, un medico o un prete: uno che aveva il suo mestiere per mantenersi, cercava di svolgerlo con il massimo di attenzione e di cura, ma senza spegnere la passione per interpretare la Totalità. Uno fra tanti, uno come tanti, abitato però dal desiderio di vivere “come colui che ha visto molto e non ha dimenticato nulla, e come uno che vede ogni cosa per la prima volta” (J. Wisdom, Paradox and Discovery, Blackwell Publishers, Oxford 1966, pp. 137-138).
Di storici delle filosofie ne abbiamo molti, e tra questi anche di molto bravi nell’esegesi dei testi in ogni lingua antica o moderna. Ma di cercatori di sapienza, che si sforzino – in e oltre la propria attività lavorativa – di pensare con originalità senza asservirsi né alla carriera né alle mode né ai potenti di turno, abbiamo disperato bisogno.
Augusto Cavadi


