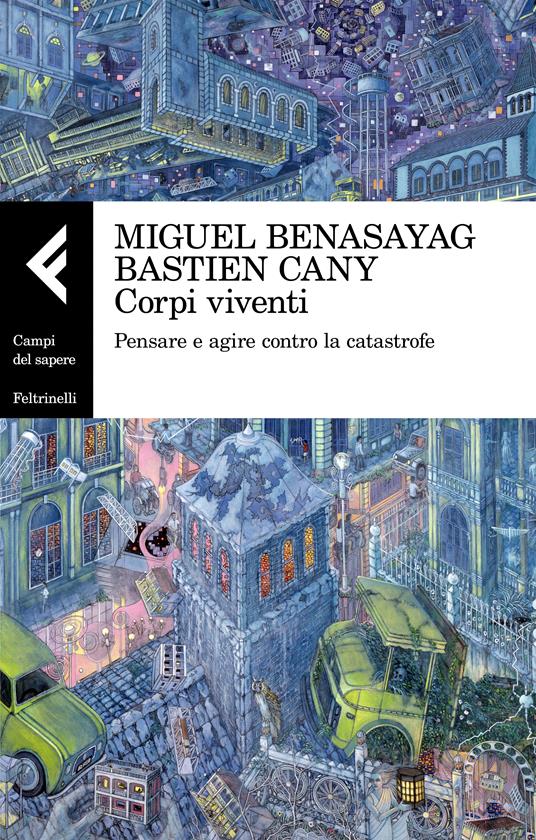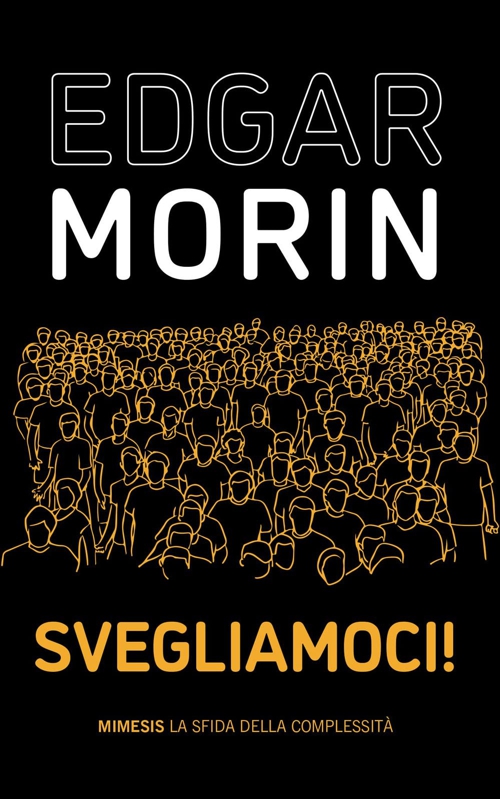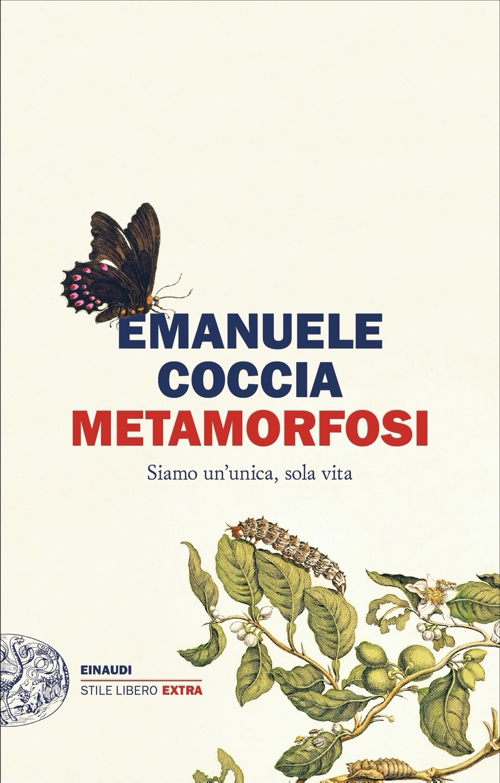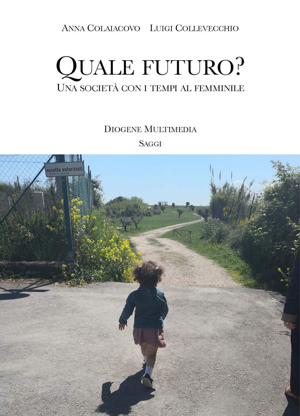• Anna Colaiacovo •

Come nasce Tetsugaku
Noi occidentali abbiamo da almeno 2500 anni, nel nostro vocabolario, la parola ‘filosofia’. Ne conosciamo il significato, sappiamo all’incirca quando è nata e in quale territorio: la Grecia. Lo stesso termine, nella forma ideografica giapponese, è nato, invece, in tempi molto vicini al nostro, nel 1874, con la pubblicazione di un’opera di Nishi Amane, uno dei pionieri degli studi occidentali, piuttosto frequenti in quel periodo storico tra gli intellettuali più aperti del Giappone. Nishi utilizzò per la prima volta, per indicare la filosofia, una parola che continua ancora oggi ad essere utilizzata: tetsugaku. È formata da due ideogrammi: tetsu (vivacità intellettuale) e gaku (insegnamento, studio). Gli studiosi giapponesi, non avendo termini propri per indicare le conoscenze filosofiche occidentali, hanno dovuto formare molti neologismi che, per la diversa struttura delle lingue, spesso non rimandano allo stesso significato nella lingua originale.
Lingue alfabetiche: hanno una struttura logico-sintetica. Si tende alla definizione della cosa nominata; il nome è la cosa stessa.
Lingue che utilizzano ideogrammi: hanno una struttura dialogico-analitica. Tendono a determinare una relazione tra chi parla e la cosa, a indicare ciò che il rapporto con la cosa produce nell’essere umano.
I termini filosofici che vengono utilizzati, oggi, nella filosofia giapponese sono stati in linea generale tradotti dal tedesco e dall’inglese. I neologismi che sono stati creati non risultano dalla creazione di un nuovo ideogramma, ma da un accorpamento di due o più ideogrammi già esistenti, aventi un significato proprio nella lingua giapponese. Ad es. i due ideogrammi che traducono il termine ‘filosofia’, ovvero Tetsu e gaku rinviano a presupposti speculativi tipici del Giappone. Per questo motivo è fondamentale, per comprendere la filosofia giapponese, analizzare la specificità del pensiero giapponese prima dell’incontro con l’Occidente (una storia di almeno dieci secoli), perché è dentro quel pensiero che viene accolto il nuovo, il pensiero occidentale.
Noi occidentali abbiamo da almeno 2500 anni, nel nostro vocabolario, la parola ‘filosofia’. Ne conosciamo il significato, sappiamo all’incirca quando è nata e in quale territorio: la Grecia. Lo stesso termine, nella forma ideografica giapponese, è nato, invece, in tempi molto vicini al nostro, nel 1874, con la pubblicazione di un’opera di Nishi Amane, uno dei pionieri degli studi occidentali, piuttosto frequenti in quel periodo storico tra gli intellettuali più aperti del Giappone. Nishi utilizzò per la prima volta, per indicare la filosofia, una parola che continua ancora oggi ad essere utilizzata: tetsugaku. È formata da due ideogrammi: tetsu (vivacità intellettuale) e gaku (insegnamento, studio). Gli studiosi giapponesi, non avendo termini propri per indicare le conoscenze filosofiche occidentali, hanno dovuto formare molti neologismi che, per la diversa struttura delle lingue, spesso non rimandano allo stesso significato nella lingua originale.
Lingue alfabetiche: hanno una struttura logico-sintetica. Si tende alla definizione della cosa nominata; il nome è la cosa stessa.
Lingue che utilizzano ideogrammi: hanno una struttura dialogico-analitica. Tendono a determinare una relazione tra chi parla e la cosa, a indicare ciò che il rapporto con la cosa produce nell’essere umano.
I termini filosofici che vengono utilizzati, oggi, nella filosofia giapponese sono stati in linea generale tradotti dal tedesco e dall’inglese. I neologismi che sono stati creati non risultano dalla creazione di un nuovo ideogramma, ma da un accorpamento di due o più ideogrammi già esistenti, aventi un significato proprio nella lingua giapponese. Ad es. i due ideogrammi che traducono il termine ‘filosofia’, ovvero Tetsu e gaku rinviano a presupposti speculativi tipici del Giappone. Per questo motivo è fondamentale, per comprendere la filosofia giapponese, analizzare la specificità del pensiero giapponese prima dell’incontro con l’Occidente (una storia di almeno dieci secoli), perché è dentro quel pensiero che viene accolto il nuovo, il pensiero occidentale.